Nel precedente articolo di questa serie ho evidenziato come i mondi secondari pullulino di società che, in modo più o meno evidente, si rifanno al modello patriarcale. Come diciamo spesso, per poter avere un futuro differente dobbiamo prima immaginarlo: e il fatto che le letterature dell’immaginazione siano tuttora ancorate al sistemale patriarcale è qualcosa che suscita preoccupazione. Non se ne può, tuttavia, fare una colpa a chi scrive: gli studi critici del femminismo intersezionale non si sono ancora diffusi in modo sufficientemente trasversale da portarci a pretendere questo livello di consapevolezza (oltre al fatto che, ovviamente, non sempre chi scrive desidera ragionare sui messaggi impliciti nei propri testi).
Di contro, c’è anche chi prende in mano la penna e, con le migliori intenzioni, procede a mettere in discussione il sistema patriarcale. O almeno, a provarci.
Società matriarcali: un’alternativa al patriarcato?
Il modello di società che viene di frequente contrapposto al patriarcato è il matriarcato. Dal momento che il termine patriarcato significa letteralmente “dominio dei padri”, si tende a identificare il matriarcato in modo analogo, cioè “dominio delle madri”. È un comune equivoco, e non dissimile da quello ancora esistente riguardo al femminismo (presentato talvolta come specchio del maschilismo, talvolta osteggiato per quella desinenza in –ismo che lo accomuna a movimenti storici di tutt’altra natura).
Ma, per equivoco che sia, i matriarcati che troviamo nella letteratura fantastica appartengono proprio a questo tipo: scambiano cioè il genere delle persone al potere, mantenendo di fatto inalterato l’impianto patriarcale (vedi “Le rovine di Isis” di M. Zimmer-Bradley, oppure “The gender game” di B. Forrest). Non credo sia una sorpresa per nessuno che questi mondi secondari siano ben lontani dall’essere paradisi – ma la conseguenza che se ne trae non è una critica del sistema di valori patriarcale, bensì l’idea piuttosto pervicace che se le donne avessero il potere si comporterebbero pari agli uomini, se non peggio. E dire che basterebbe dare uno sguardo alle attuali leader politiche femminili, per rendersi conto che non basta avere una donna al comando per ritenere una società matriarcale…
Il matriarcato, ovvero “All’inizio, le madri”
Gli studiosi che hanno passato al setaccio la nostra documentazione storica ed etnologica alla ricerca di società dominate da donne in senso patriarcale non hanno, ovviamente, trovato nulla: questo ha contribuito a lungo a considerare il patriarcato come naturale, innato, la prima e unica forma in cui l’essere umano si sia mai organizzato.
Questa visione ha iniziato a essere messa in discussione a partire dagli anni ’70. Scrive H. Goettner-Abendroth nel suo saggio “Le società matriarcali del passato e la nascita del patriarcato”,
Le società matriarcali non sono l’immagine speculare di quelle patriarcali, ma rappresentano una forma sociale completamente diversa, che è perdurata a lungo nella storia culturale degli inizi. Pertanto, è sbagliato tradurre matriarcato con “dominio delle madri” o peggio “dominio delle donne”, mentre “all’inizio le madri” descrive con precisione il contesto.
Una ridefinizione del concetto di matriarcato svincolata dal sistema patriarcale e basata su società indigene ancora esistenti mostrerà perciò una realtà molto differente da quella propagandata dalla storiografia classica, in cui possono trovare spazio anche nuove narrazioni del fantastico.
Matriarcato: una definizione strutturale
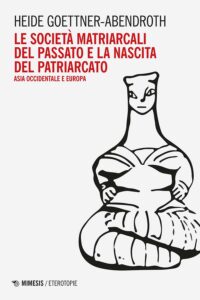
La definizione di matriarcato presentata da Goettner-Abendroth è strutturale: si basa sull’osservazione analitica di queste stesse società, e ne riconosce i principali caratteri economici, sociali, culturali e politici. Perciò, la forma sociale matriarcale è:
- a livello economico, una società di reciprocità basata su un’economia in equilibrio, in cui le donne gestiscono i beni essenziali come la terra, la casa e il cibo, cercando di mantenere bilanciata la ricchezza attraverso la ridistribuzione;
- a livello sociale è basata sulla parentela matrilineare, la cui caratteristica principale è l’organizzazione di clan fondati sulla matrilinea (parentela in linea materna) e la matrilocalità (residenza presso la madre o nelle sue vicinanze). Al suo interno i sessi sono considerati paritari (parità di genere);
- a livello politico si conferma come una società del consenso, basata sulla politica locale esercitata nelle case del clan e su un sistema di delega affidato agli uomini;
- a livello culturale è una cultura caratterizzata da complessi sistemi religiosi e ideologici, dove la credenza nella reincarnazione costituisce la concezione di base della vita terrena e cosmica.
Sulla base di questa definizione, i cosiddetti matriarcati della letteratura fantastica si riducono fino quasi a sparire – anche perché i rarissimi romanzi che presentano una forma sociale come quella appena descritta non vengono chiamati matriarcati (cosa che di certo non aiuta a colmare questo buco).
La società matriarcale di “The Tropic of Serpents”
Il secondo volume delle avventure di Lady Trent iniziate con “A Natural History of Dragons” si intitola “The Tropic of Serpents” e sfrutta a fondo le ampie conoscenze antropologiche ed etnografiche dell’autrice M. Brennan.

Nel proseguo delle sue esplorazioni di ricerca sulle tracce dei draghi del proprio mondo, la biologa Isabella entra in contatto con una civiltà indigena radicalmente diversa dalla propria, integrata nel proprio ambiente naturale (per quanto riguarda il discorso sull’ecologia fantastica, rimando a questo articolo) e con tutte le caratteristiche di matriarcato elencate poco sopra.
La familiarità di Brennan per l’opera di Goettner-Abendroth emerge in più punti. Un esempio su tutti è la natura delle relazioni parentali, in cui possiamo mettere direttamente a confronto il saggio di Goettner-Abendroth con il testo di Brennan:
La flessibilità di queste cerchie non consente il formarsi di vere e proprie genealogie, né tra i San né tra i Pigmei. Le donne riconoscono i loro figli naturali secondo una rudimentale linea materna, che però si estende solo alla generazione successiva, non oltre. Ci sono poi le cosiddette “nonne”, le donne anziane che aiutano le più giovani con i bambini e che ne garantiscono la sopravvivenza. La domanda è se questo significhi un’effettiva parentela o solo una definizione basata sull’età. All’interno di ogni classe di età i membri si chiamano tra loro “sorella” e “fratello”, riferendosi non alla parentela di sangue ma al fatto che la loro età è simile. Allo stesso modo, tutte le donne con figli sono collettivamente “madri” e il gruppo di donne anziane che le aiuta è chiamato “nonne”, o così almeno le definiscono i ricercatori, data l’abitudine a questo concetto. – Goettner-Abendroth, Heide. Le società matriarcali del passato e la nascita del patriarcato, Mimesis Edizioni.
This, we came to understand, was the source of our confusion over Faj Rawango’s greeting to the others. Natchekavu and Eguamiche were his “brothers” in the sense that they were men of his own generation, nothing more. Claims that the Moulish have no concept of “family” are not true; they acknowledge that some people are the sons and daughters of the same parents, and such relatives often work together when they are in the same camp. But all those of a given age group within the camp are brothers and sisters, as all those above them are mothers and fathers, or (if older still) the camp’s elders. Faj Rawango calling those two his brothers was simply a way of claiming the right to join their camp, and to bring the three of us with him. – Brennan, Marie. The Tropic of Serpents: A Memoir by Lady Trent (A Natural History of Dragons Book 2). Tor Publishing Group.
Nel suo complesso, il romanzo di Brennan svolge un lavoro davvero egregio nel farci familiarizzare con una cultura radicalmente diversa dalla nostra. La cosa interessante è che non vengono dati giudizi di valore: la società Moulish non è intrinsecamente migliore della nostra (una deriva che porterebbe facilmente alla retorica paternalista del buon selvaggio, e in cui talvolta scivola anche la migliore critica), ma ne rappresenta un’alternativa. Scoprirlo consente alla protagonista di mettere in prospettiva le difficoltà affrontate fino a quel punto (legate al suo essere donna in un mondo tradizionalmente patriarcale), e individuare strade di guarigione e resistenza che non sarebbero state a sua disposizione nel suo contesto precedente.
In questo senso, “The Tropic of Serpents” si dimostra un esempio eccezionale di come la consapevolezza delle strutture patriarcali e delle sue alternative esistenti possa arricchire la narrazione fantastica, senza andare a scapito di una storia avvincente.




